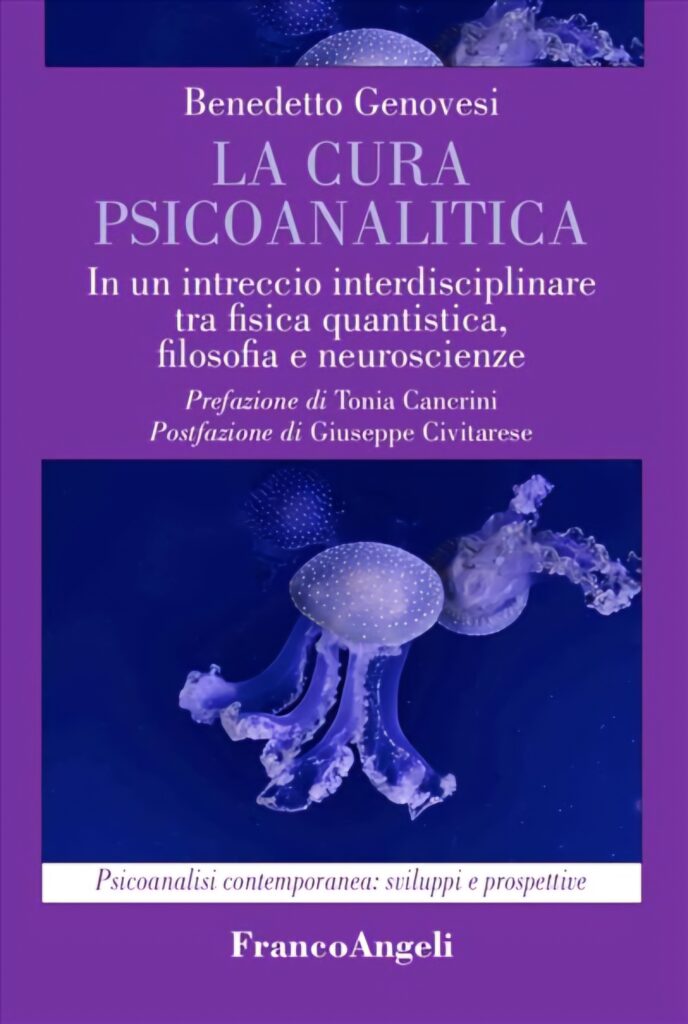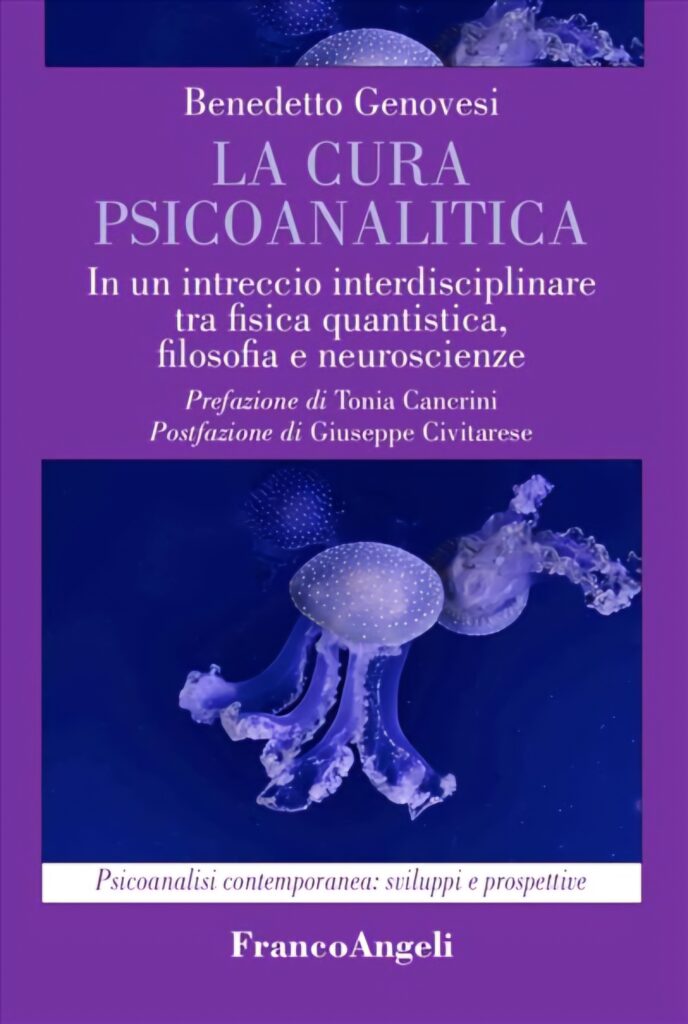Rossana Gentile
Recensione al testo: La cura psicoanalitica , Benedetto Genovesi , Franco Angeli, Milano 2024
«Gli alberi hanno qualcosa in comune con il nostro sistema nervoso. Sono un po’ come noi.Le radici degli alberi stanno dentro di noi, alle nostre origini. Sotto i nostri piedi ».
Con queste parole B. Genovesi ci introduce al suo testo che ci piace considerare come una
«passeggiata tra i saperi». Con ‘andamento lento’, (per citare il titolo di una nota canzone del
batterista napoletano Tullio De Piscopo), da buon siciliano Genovesi cammina sulle sue radici e
sembra coinvolgerci nel ritmo entusiasta e carico di sorpresa della sua camminata: rintracciamo in
questo bel libro la sua passione per la psicoanalisi, il debito di riconoscenza e l’affetto per i
maestri, i testi che lo hanno sostenuto nelle sue ‘esplorazioni’ che lui stesso paragona ad una
navigazione in mare aperto.
Ritroviamo qui quella curiosità innata dei bambini, effetto della pulsione epistemofilica al lavoro, di
cui parlano M. Klein (1932) e Freud (1910), pulsione che si annida in ciascuno di noi alimentando il
desiderio di sapere e la spinta vitale ad esprimere l’amore in tutte le sue sfumature.
Genovesi spazia dalle neuroscienze alla letteratura, alla fisica quantistica, sempre evidenziando un
ancoraggio saldo alla psicoanalisi, di cui ricorda i punti fermi, gli approdi, per mantenere la
metafora marina: uno di questi è la trama delle relazioni e degli scambi affettivi all’origine dei
processi di crescita e di costituzione dell’identità di ciascuno. Sin dalla nascita siamo immersi in un
campo relazionale caratterizzato da scambi che determinano un costante e continuo influenzamento
reciproco tra soggetti, esattamente come accade tra le particelle che formano la materia, secondo
quanto apprendiamo dalla fisica quantistica. Seppure da diverse prospettive, sia Winnicott che Bion
hanno dedicato gran parte della loro attività teorica e clinica a confermare questo importante aspetto
della vita umana. Il primo, affermando che all’inizio della vita è impensabile che un bambino possa
esistere senza una madre o comunque un ambiente di accudimento che ne sostenga lo sviluppo
maturativo, il secondo sottolineando che ciascun essere umano è costituzionalmente dotato di una
«valenza» (termine preso a prestito dalla chimica), ovvero una tendenza spontanea a creare legami
emotivi con gli oggetti. Siamo dunque attraversati da connessioni, relazioni, trasformazioni, sia che
ci riferiamo ai vari aspetti della vita pulsionale che alle molteplici e complesse forme della vita
relazionale. Genovesi, in linea con quanto sostengono Civitarese e Ferro (2015), ricorda che nella
situazione analitica analizzato e analista si incontrano come due soggetti che generando con i loro
corpi, le loro emozioni, i pensieri, un campo relazionale, inteso come «terzo soggetto, frutto della
loro interrelazione» .
Molto belle le immagini che Genovesi ci propone, a cominciare da quella del neurone che” da solo
non va da nessuna parte”: l’immagine, a mio avviso, è molto efficace nel suggerire quegli stati
psichici caratterizzati da disorientamento, solitudine e senso del vuoto. Genovesi procede così, con
la potenza delle immagini evoca e narra le vicende dell’ esistere nell’universo, dove il movimento
che si realizza da un punto all’altro, da una direzione all’altra, nelle infinite forme che si possono
realizzare nello spazio e nel tempo, sembra riflettere l’infinità complessità dell’inconscio, da cui si
genera la corteccia delle emozioni nella quale si inscrive la storia di ciascuno.
Un’altra immagine molto bella riguarda proprio il rapporto tra analista e analizzando «…nuotano
nello stesso mare, affinché si possa giungere, di tanto in tanto, a qualche isola dell’oceano.
L’analista deve, in qualche modo, condurre il processo analitico dell’ analizzando. Se nuotiamo in
mare e siamo in compagnia di qualche altro, nuotando in scia con qualche altro nuotatore che ci
precede, andiamo più veloci. Infatti, il nuotatore che ci precede, con il suo battito delle gambe, crea
un vortice d’acqua che ci aspira, ci tira, come fosse un filo invisibile che ci traina».
La pulsazione delle immagini che via via si incontrano nel testo imprime ritmo e armonia al
pensiero del lettore lasciandolo libero di sintonizzarsi e fantasticare sulle molteplici sollecitazioni e
suggestioni che lo attraversano. Ciascuno, potremmo dire, alla fine crea questo libro in sintonia con
le sue personali evocazioni emotive, culturali, storiche. Un po’ come accade con un’opera d’arte.
Concordo con quanto scrive Civitarese nella postfazione. Nella sua semplicità e leggerezza, questo
testo è in effetti complesso. Evocativo, più che scientifico in senso stretto, non è stato scritto con
l’intento di approfondire e modulare i passaggi tra un costrutto teorico e l’altro, una citazione
bibliografica e l’altra. Si richiede al lettore di essere disponibile a orientarsi in più direzioni, di
spaziare in mare aperto, come scrive lo stesso autore nella introduzione comunicandoci di essere
lui stesso immerso in questo mare di saperi che attraversa sulla sua piccola imbarcazione
psicoanalitica, alla ricerca di un’isola nell’oceano o nel mare più ristretto e familiare delle isole
Eolie. Ma da buon conoscitore del mare e dei flussi marini, Genovesi sa di dover assecondare
l’andamento delle maree, perché questo gli consente di restare sempre lì, fermo e sicuro a osservare
il mare, come il noto personaggio che in tanti abbiamo amato e ammirato per il suo spirito
intraprendente, Corto Maltese.
E arriviamo al palamito o “ conzu “, che sembra sintetizzare in maniera magistrale lo spazio
analitico. “U conzu” è una rete costruita intorno a una superficie rotonda a più strati, agisce nel
tempo, nella durata di una notte. Potremmo dire che si basa sull’attesa, quella stessa attesa che
trasforma, in analisi, lo spazio materiale del tempo in esperienza psicologica, profonda, spirituale.
Il pescatore analista Genovesi sa che per raccogliere i pesci occorre aspettare che essi stessi arrivino
in rete. Egli ci mostra, con brevi semplificazioni cliniche, il potenziale trasformativo della relazione
analitica che si evidenzia quando il paziente realizza di essere contenuto nella mente dell’analista
che con il suo affetto, il suo pensiero, la sua presenza, imprime continuità e stabilità al suo essere
nel mondo. L’analisi può contenere tracce di esperienze passate, aspetti impensabili che attendono
di poter «essere pescati», ossia portati in campo, condivisi e metabolizzati.
L’attesa, come una rete gettata in mare , fonda lo sguardo che analista e paziente costruiscono a vari
livelli di profondità : se l’analista sa aspettare, ha fiducia nella relazione e nel dispositivo, ovvero
nel setting, il paziente ha l’impressione di scoprire da solo la sua verità, che emerge come
un “gesto spontaneo”, potremmo dire adoperando una felice espressione che Winnicott introduce
per indicare il primo atto creativo del bambino carico di sorpresa e di meraviglia che accompagna la
scoperta del mondo “là fuori”. Genovesi ci parla con semplicità di alcuni suoi pazienti. Katia
comunica all’analista, ripensandosi nel passato, di aver compreso quanto sia importante sentirsi
visti per sapere di essere vivi. E l’analista, che coglie la profondità di questa comunicazione,
sottolinea che lo sguardo analitico l’ha aiutata a sentirsi più integrata , più in contatto con se stessa e
con il mondo. Allo stesso modo, Sara dichiara che dentro di sé erano come intrecciate, in una
relazione dissociante e paralizzante, la bambina e l’adulta; grazie all’analisi, ha potuto fare
un’esperienza integrante che la ha liberata dalle paure e dalle angosce che l’avevano resa nemica di
se stessa. È grazie all’esperienza analitica che Luca, infine, coglie l’importanza di accettare i propri
limiti e tollerare gli errori. Il potersi sentire accolto e accettato ha creato, le premesse per
riconoscere dentro di sé quanto prima era vissuto come estraneo e poter iniziare a fare progetti.
L’analista , come il dermatologo, va dalla pelle alla profondità, all’interno dell’organismo: sostiene,
integra, rilancia il processo di crescita interrotto. E, come fanno i ceramisti giapponesi che
impreziosiscono i vasi rotti tenendo insieme i frammenti con il filo d’oro, rende prezioso il dolore,
trasformandolo in fonte di conoscenza e di rinnovamento.
Come osserva Tonia Cancrini nella sua bella prefazione, a volte si ha l’impressione che c’è quasi un
troppo nel testo, che rischia di far perdere il lettore, ma in effetti va sottolineata la ricchezza del
percorso personale dell’Autore, che ci accompagna in questo suo mondo fatto di meraviglia e
curiosità.
Bibliografia
G. Civitarese, A.Ferro (2015) Il campo analitico e le sue trasformazioni, Raffaello Cortina, Milano
S. Freud (1910) Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, OSF Bollati Boringhieri Vol.6
M. Klein (1932) La psicoanalisi dei bambini, Firenze, Martinelli 1970